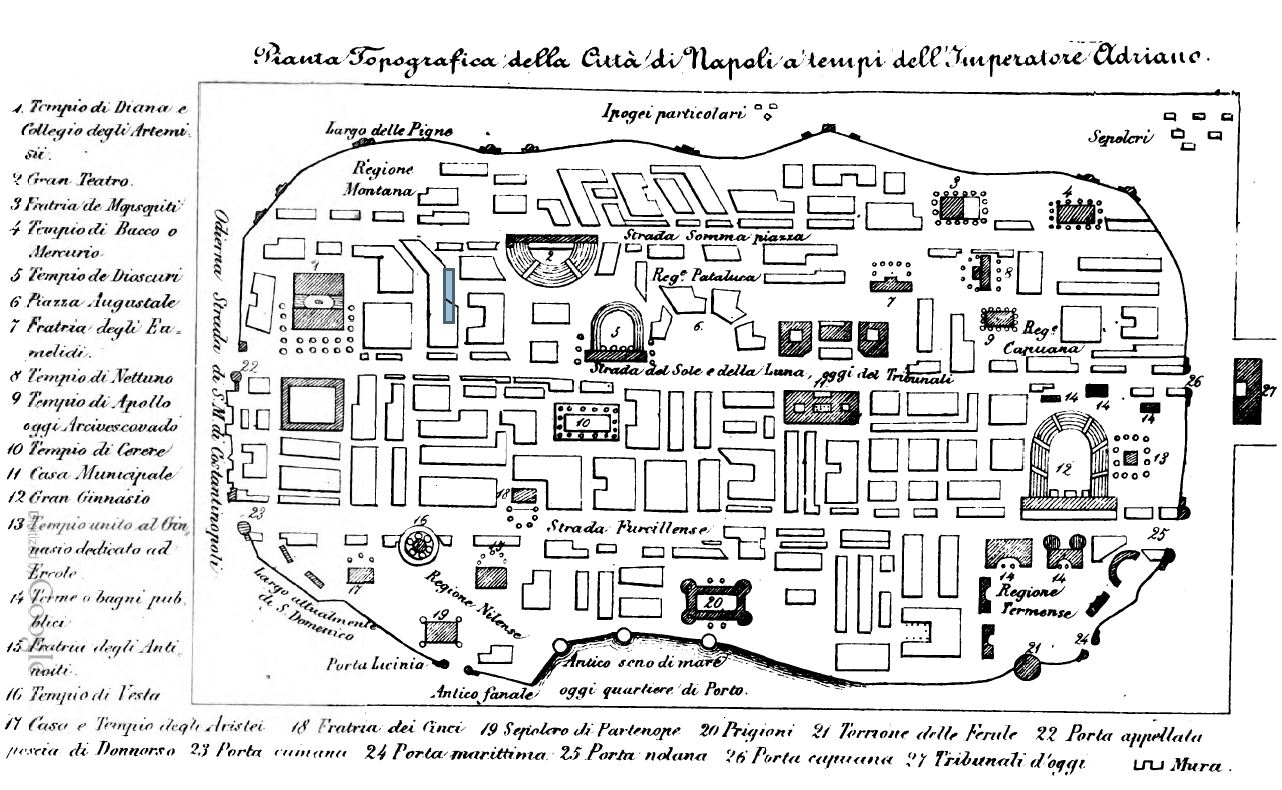NAPOLI (di Atanasio Pizzi Arch. Basile) – Attualmente si riconoscono gli ambiti detti “Arbër” come bene culturale a carattere identitario, frutto della percezione linguistica della popolazione, assumendone per questo la funzione di bene non statico, ma dinamico e, nel tempo mutabile, sotto specie di espressione folcloristica o ricerca senza inizio e fine.
NAPOLI (di Atanasio Pizzi Arch. Basile) – Attualmente si riconoscono gli ambiti detti “Arbër” come bene culturale a carattere identitario, frutto della percezione linguistica della popolazione, assumendone per questo la funzione di bene non statico, ma dinamico e, nel tempo mutabile, sotto specie di espressione folcloristica o ricerca senza inizio e fine.
I radicali sviluppi economici, sociali, tecnologici e politici, avvenuti durante il ventesimo secolo, ne sono prova evidente, viste le continue violazioni identitarie, passate inosservate, sin anche al vaglio dei preposti, che leggono carte prive di confronto sul territorio, perché il dovere istituzionale, vuole gli addetti rigorosamente seduti in ufficio.
L’esigenza sfrenata di dover diffondere storia, con capitolazioni, atti notarili e matrimoni, ha fatto allestire irresponsabili, atti per poi attribuirli ai centri urbani detti minori e se questi fanno parte di quelli contemplati nella legge 482 del 99, “il dado è tratto”, ma purtroppo in questo caso, non esiste nessun ponte da attraversare, in quanto ancora neanche in allestimento.
Se a questo si aggiunge l’accelerato sviluppo tecnologico/scientifico, associato all’utilizzo di mezzi di comunicazione e trasporto di massa, tutto è mutato radicalmente il modo di vivere e lavorare, ricorrendo a materiali sperimentali, non più del luogo.
L’industrializzazione e l’agricoltura meccanizzata hanno modificati i luoghi agresti, terminando nell’abbandonare in molti casi, gli storici cunei agrari o della trasformazione, nonostante l’irripetibile eccellenza locale, un tempo filiera, non ripetibile in altri luoghi.
Eppure, comparativamente pochi tra i siti e i luoghi creati da eventi, sia tumultuosi, sia naturali e del genio locale, sono stati iscritti negli elenchi dei beni da tutelare, perché patrimonio culturale o luoghi della inimitabile “Dieta Mediterranea” o “Trittico Mediterraneo dell’alimentazione”.
Per questo, sono troppe le “Regioni Storiche dell’alimentazione Prima”, a rischio terminazione o già estinte, per ragioni politiche di radice globale, divenute nel contempo flebile memoria di una eccellenza che i locali ignorano o non hanno numeri e cose per riconoscerla.
Di contro si apprezza e si agevola senza alcuna regola, l’architettura moderna del secolo appena trascorso e, l’insieme di edifici, strutture e percorsi rotabili; tutto viene stravolto a favore di una cultura priva di solidità, ma esposta a una generale mancanza di consapevolezza o riconoscimento di luogo.
Tutto questo avviene perché, quanti dovrebbe assumere il ruolo di controllo, non conoscendo la storia del territorio di competenza, di punto, di luogo agreste e dei centri antichi di origine.
Troppo spesso gli ameni locali, sono sottoposti a processi di riqualificazione o modifiche inappropriate e, “perché abbandonati”, sono inseriti in processi di modernizzazione, che non hanno nulla a che vedere o fare con i valori distintivi per i quali furono allestiti ad uso comune e privato.
Qui in questo breve, si mira a difendere tutto ciò, in particolar modo, tutti gli elevati primi, e sin anche la toponomastica di memoria storica, realizzate e appellata dall’uomo e, siccome questi sono ambiti e cose minori, non si prevedono sanzioni, verso quanti ne violano i contenuti e il significato di elevati e strade, in quanto prive di paternità progettuale.
Questo purtroppo avviene perché non è stato codificati o ritenuto storicamente attendibile quello che si possiede, quindi fa parte della categoria dei non tutelabili, indifesi, o meglio posti alla disponibilità, della sovranità locale, che non conosce e ignora totalmente la storia di luogo, ritenuta favola di casa che non va oltre il perimetro del proprio focolare domestico.
E nonostante questi luoghi siano stati, colmi di storia prima e o momenti fondamentali delle vicende locali che contano ma senza nome, pur se estremi assoluti, nel rispondere a esigenze o bisogni distintivi della storia, in tutto, opere senza clamore, sono ritenute per questo violabili.
E’ in questo modo che si offende continuamente la memoria dei luoghi, ma più di ogni altra cosa, le conquiste della comunità ad opera di singoli che così facendo diventano storia dell’architettura anonima.
La stessa che non trova ristoro nel cuore e nella mente, dei comuni mortali vernacolari attività, per le quali se ti confronti con tema di tutela, si preferiscono luoghi di tragedia, opere d’un autore, monumenti, chiese, facciata di palazzi nobiliari, un campanile, un ponte, un rudere confermato, ma non quello che resta chiuso dell’intimità di costruttori anonimi locali, che per la loro indole prima, restano silenziosi e non lamentano alcun che.
Nessuno conosce misura, nessuno da conto, nessuno prende atto della violenza prodotta, nel mutare una parete, cambiarne i pigmenti, dismettere appellativi viari, apporre scalfiti dii memoria, o ritenere sia giusto rendere il centro antico momento di raffigurazioni e non di vita produttiva e conviviale, ma mera finzione filmo/figurativa.
I comun preposti, invece di prodigarsi nel difendere la propria identità di luogo, preferiscono i valori di mastodontici monumenti, appariscenti attività di pigmento e, non identità anonima locale senza nome, per questo si sentono delegati a vituperarli, violarli o coprirli di pena.
L’Architettura senza architetti, identificata come Vernacolare, mirava al semplice valore del costruito per bisogno, introducendo valori propri di uno specifico luogo, senza pedigree di architettura, ne violare la natura circostante.
Essa è così poco nota che non esiste neppure un nome specifico per identificarla o un’etichetta generica, ma possiamo chiamarla nel comune dialogare, Povera ( i Nëmurh), Spontanea (e drechjurë), rurale, indigena (llitirë), o genio locale (Mieshëter Arbër) a seconda dei casi di studio.
Naturalmente entra nello scopo di questo tema, fornire una storia coerente dell’architettura senza valore, e lungi dal sortire in tipologie o definizioni tipologiche sommarie.
Essa deve aiutare a liberarci dalla ristretta classificazione di architetture ufficiali e commerciali, che facilmente sono replicabili perché di paternità illuminata.
Gli studi forniti da numerosi e nobili autori, presi come solidi riferimenti, inquadrano con forza l’architettura senza autori, e oltre a ciò consentono di rielaborare il significato di alcuni termini, quali architettura “Spontanea” (e drechjurë), “Minore”(e Viker) e “Anonima”( e Guej), operazione utile a definire il contesto di riferimento specifico della ricerca.
Il lessico fornisce la precisazione di significato soprattutto per evitare di dare origine a fraintendimenti o ad usi impropri di termini apparentemente o foneticamente simili.
È necessario approfondire quei termini, i quali, nel tempo sono stati usati, con molteplici accezioni, per descrivere un fenomeno che spesso è stato ridotto al concetto di “spontaneo” (e drechjurë), quando la spontaneità mira a restituire supporto fondamentale alla vivibilità di questi luoghi, siano essi agresti che concentrati in forma di Katundë.
Nella storia, l’aggettivo Vernacolare, in questo specifico caso potremmo appellare “Architettura in Arbanon”, più volte usato per indicare un linguaggio non accademico, ma serie di opere povere, esigenza di luogo, legate a contesti molto ristretti, costruiti con materiali del luogo e tecniche tradizionali, provate sulla pelle dei usufruitoti di famiglia allargata, sin a raggiungere l’equilibrio ricercato.
Il fatto che spesso si sia parlato di architettura spontanea, come sinonimo di architettura povera, è senz’altro un atteggiamento per delegittimare le opere non riconducibili ad un preciso progettista; ciò avviene sovente perché tali forme architettoniche sono frutto di esperienze stratificate nel tempo, legate ad esigenze prime che vengono svolte e risolte in modo collettivo, non riconducibili ad una corrente, ad una figura nota, ad un autore, in quanto esigenza abitativa locale o agreste, di un ben identificato momento storico, fuori dai circuiti della divulgazione.
L’aggettivo spontaneo, pertanto è attribuibile a ciò che non ha imposizioni definite da una scuola o una tendenza generale o ampia, ma esigenza di luogo, tessuto con materiali locali offerti dagli eventi della natura.
Questa caratteristica, in riferimento alla trattazione di un tema come l’architettura anonima, nella contemporaneità, comprende il non essere assoggettato o influenzato da un linguaggio particolare o da uno stile, anche se la spontaneità lega aree ben definite o esigenze, germoglio di ambiti collinari o di approdo mediterranei secondo i bisogni delle genti che si preparavano a risiedervi senza soluzione di tempo, cose ed eventi.
Con l’idea di architettura spontanea, dunque, non è l’architetto-artefice, ma piuttosto una sorta di razionalità collettiva che, rispettando le norme non scritte, per la gestione dello spazio, risolve diversamente il dato estetico, culturale, di utilità associata al territorio.
Tale condizione di spontaneità è associabile, nel caso dell’architettura, a forme e soluzioni di una architettura codificata con consapevolezza, e poste alla verifica delle stagioni e la natura di un ben identificato luogo.
Ritrovando i valori della ricerca di questo breve, anche negli studi condotti da Rudofsky, non è un caso, che le tipologie edilizie tradizionali di genio arbëreshë, sprezzate o del tutto ignorate dagli studiosi comuni, per questo rimaste testimonianza silenziosa, grazie alla spinta di questo maestro delle indagini del costruito minore, si aggiunge un valore assoluto e non indifferente.
Quanti considera ancora oggi le architetture minori degli Arbër poca cosa per l’indagine storica al fine d’individuare percorsi della “regione storica diffusa” e quelle delle terre parallele ad est del fiume Adriatico, commettono e portano avanti consistenti negligenze di studio e approfondimento identitario.
Infatti le architetture locali della regione storica, attingono le radici dall’esperienza umana, interesse di studio che va oltre quello tecnico ed estetico, inquanto tratta di un’architettura senza dogmi.
A tal proposito è il caso di approfondire le cose che caratterizzano dal punto di vista costruttivo e dell’ambiente naturale i cento Katundë di origine arbëreshë, del meridione d’Italia, relativamente al costruito riferito come primo, che va dal XIV secolo al XVIII con evidenti elementi distributivi, tipologici in continua aderenza con lo sviluppo del territorio, in convivenza fraterna tra gli uomini.
Noti come Katoj, Motticelle o Kallive, si legge facilmente la radice organizzativa di espressione monastica, visto e considerato che i gruppi familiari che componevano gli abitanti di ogni agglomerato, aveva un prete ortodosso e la sua famiglia come elemento di credenza trainante.
Confermato che tutta la popolazione si sosteneva con le attività agro silvo pastorali, in estate o nella buona stagione quando l’attesa dei risultati di semina, consentivano di avere tempo per le attività degli anonimi e infaticabili Arbër, questi genio e forza lavoro a innalzare gli abituri tipici, suggeriti dai preti locali, nelle distribuzioni interne, a impronta di quelli monastici vissuti durante la loro formazione, è così che ha inizio la delimitazione del cortile e la piantumazione dell’orto botanico.
Cattedratici e studiosi post legge 482/99 ostinatamente e senza ragione confermavano, “tutti che non è cosi”, ma quando nel 2013 la difesa di Cavallerizzo e le motivazioni depositate nei preposti uffici, crearono scompiglio nel campo del genio culturale scritto, in greco e latino ignoto.
Costringendo a disporsi negli angoli bui, quanti con le teorie catastali senza verifica locale, volevano fare opera senza conoscere la storia, ritenendo possibile innalzare un paese “Arbëreshë con le Gjitonia” e attorno alle attività di difesa per gli Arbër, fu deserto algerino a prevalere e nulla più.
E quando oggi si confrontano i disegni per lo studio dei moduli abitativi dell’unità di Abitazione di Marsiglia, del noto Le Corbusier, si ritrovano elementi di spazio essenziali, sin anche delle finestrature e i sotto moduli di areazione naturale, con finalità pari, simili, equipollente o rivisitati dei moduli tipo, di Katoi, Motticelle e Kalive, ancora pronte a dire la loro, in campo dell’architettura vernacolare in terra Arbër.
Lo studio dell’architettura anche se anomia o vernacolare, segno indelebile di genio locale, se si ha formazione sufficiente, nulla sfugge al buon osservatore fornito con occhio in fronte e nella mente.
L’architettura ha date, tempi, luoghi e uomini, per ogni epoca, essa non lascia spazi a libere interpretazioni, come avviene con la favola onnipresente, che vuole la letteratura Arbër, elevarsi solo dopo il 1831.
A questo punto viene da chiedersi: prima della letteratura di terzo decennio, dell’ottocento, cosa facevano i minoritari di Calabria Citra, dormivano, si cullavano, pascolavano pascendo.
Voi che fate la coda in archivio e in biblioteca, ancora non avete trovato gli atti del palazzo arcivescovile di Santa Sofia datato 1595, dell’omonimo di San Benedetto Ullano, datato 1625 e, nulla del Collegio Corsini dal 1742 con le innumerevoli eccellenze vescovii le sue eccellenze di cultura, scritta e orale, compilati prima di ogni altra figura, dal Baffi a partire dal 1765 a Salerno e magari, quando ritrovati addirittura copiati senza vergogna, per poi stamparli diffusamente a Napoli